Dalla notte dei tempi erano i vecchi che insegnavano ai bambini, ora sono i ragazzi che insegnano ai nonni (ma anche ai genitori) come maneggiare il computer, usare il telefonino, destreggiarsi su social e facebook. Ed è passata appena una generazione. Ecco il motivo per cui Roberto Stevanato, già docente universitario di Ca’Foscari, presidente del Centro studi storici di Mestre, ha deciso di scrivere “Gavemo le cape, fèmene”. Trecento pagine, fitte fitte, per testimoniare alle nuove generazioni, native digitali, cosa si sono perse abbandonando la cultura contadina. Nato nel 1946, originario di Chirignago, scrive con una leggera vena polemica di chi “è sempre vissuto nella periferia ovest di Mestre” con cui ha condiviso l’emarginazione dal dopoguerra ai nostri giorni. Una cultura di terraferma e mestrina, da tenere ben separata da quella veneziana.
Le cape di Stevanato

La mia generazione del primo Dopoguerra – chiarisce Roberto Stevanato – ha vissuto in modo violento questo cambiamento epocale. Infanzia ancora legata alla vita dei campi, senza telefono e televisione, ma con stalla, pollaio e porcile. Passata in pochi decenni del cosiddetto benessere, alle sirene dei jukebox, delle lambrette e vespa (per pura coincidenza nate nel 1946…), del rock’n’roll, della rivoluzione sessuale. Tra la generazione precedente e quella successiva, un divario di secoli.
Colpiscono i ricordi dell’infanzia della vecchia casa colonica di Chirignago. La campagna distante anni luce, dai “signori” di Venezia.
I tempi di Porto Marghera

Nel libro si insiste parecchio sulla rivoluzione creata da Porto Marghera, che proprio Marghera non era, semmai Bottenigo o Bottenighi. In fondo quel toponimo, era il nome della torre medievale di San Giuliano.
In pochi decenni siamo arrivati a 40 mila operai, come ricordava in una fortunata rubrica fissa il Gazzettino. Metà dipendenti arrivavano da Venezia (Arsenale, Giudecca e dintorni) mentre l’altra metà, lasciata la campagna e la cultura contadina, proveniva dalla terraferma veneziana. Fu così che Mestre, ridente cittadina con canali e fiumi di 16 mila abitanti, che lo stesso Carlo Goldoni, osava definire “una piccola Versailles”, venne travolta da un boom edilizio senza regole e con tanti affari. Senza piani regolatori e con condomini abusivi che sorgevano come funghi.
Uno dei capitoli più ficcanti, oltre alle storie dei contadini dei comuni autonomi di Chirignago, Favaro, Zelarino, eliminati assieme a Mestre nel 1926, per creare la “grande Venezia”, é la frenesia affaristica di tale Bepi Boassa. “Zente refada”, direbbe Giacinto Gallina, con poca cultura, ma tanta “ciacola” che riesce in pochi anni, assieme a “giometri” e tecnici comunali senza scrupoli, a metter sù una fortuna patrimoniale.
Gavemo le cape, fèmene!
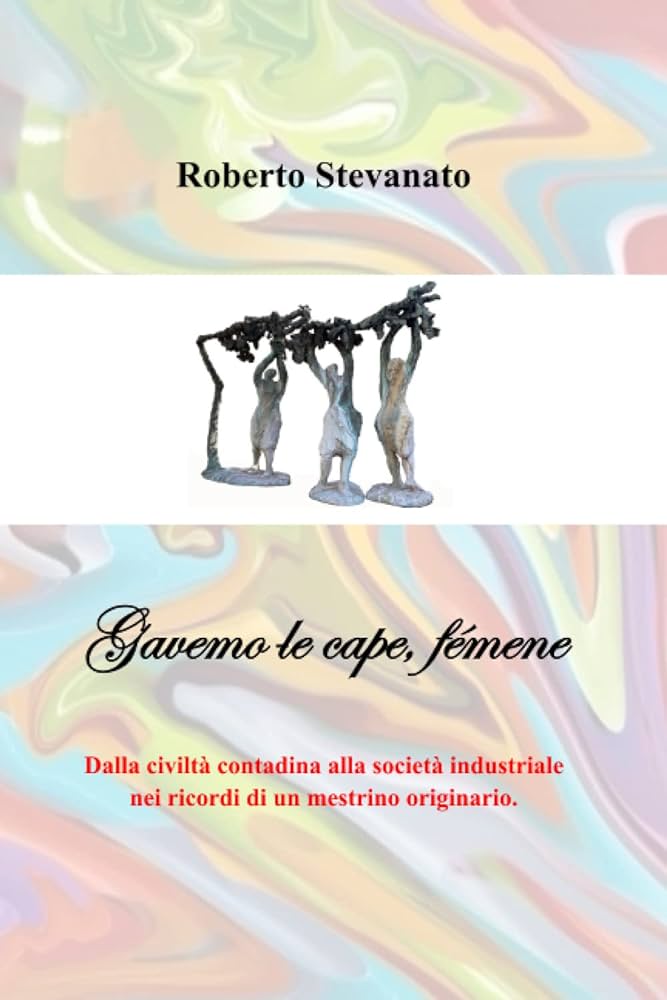
Nel nutrito collage di racconti famigliari, Roberto Stevanato, accumula un mosaico di vita rurale destinato all’estinzione, con tante parole in dialetto, ora un vero e proprio patrimonio di antropologia culturale. Azzeccato il ricordo di “Sisio dele cape”, un ambulante che a primavera andava a raccogliere i molluschi (probabilmente attorno al Seno della Sepa, bordo lagunare tra San Giuliano e Passo Campalto) per urlare tra le case rurali, con voce indistinguibile: “Gavemo le cape, fèmene!”. Prezzo fisso per “tre manate di caparozzoli” e spaghetti succulenti assicurati per il pranzo. “Ma oggi hai le mani più piccole Sisio?”, lo riprendevano divertite le casalinghe.
Poi, improvvisamente, tutto cambia. Nelle case appare un elettrodomestico destinato a cambiare le nostre abitudini: il televisore. Tutti chiusi in casa o al bar per assistere a “Lascia o raddoppia” con Mike Bongiorno. Infine, qualche decennio dopo, arriva la mazzata finale. Un altro strumento rivoluzionario: il telecomando.
Ciao, ciao, piccolo mondo antico.





















































































