Tra il 1930 e il 1968 la storiografia conobbe una vera e propria rivoluzione: la scuola delle Annales, sorta in Francia intorno alla rivista “Annales d’histoire économique et sociale” fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucièn Fevbre, cambiò completamente l’approccio all’analisi storica. La narrazione non si accontentava più di analizzare la successione e le motivazioni di guerre e battaglie, per quanto importanti. Vennero considerati parte integrante dell’indagine storica gli aspetti economici, vale a dire la produzione, la tecnologia, i mezzi di lavoro, come anche la mentalità, la demografia, la vita quotidiana, la sessualità, l’alimentazione, le abitudini di consumo, eccetera. La microstoria divenne importante tanto quanto la macrostoria e permise di comprendere meglio gli eventi che si andavano analizzando. Leggendo il romanzo Casa Granda di Orfeo Lorenzon, recentemente pubblicato da Ronzani nella collana Carvifoglio diretta da Bruna Graziani, non può non risuonare l’insegnamento di quella scuola.
La storia con la “S” maiuscola
La Storia, quella più recente tra le due grandi guerre attraverso una feroce e sanguinaria dittatura, viene raccontata tramite le vite e le vicende di una comunità che si muove tra le rive del Sile e la campagna trevigiana in un affresco composito e struggente. Le storie spicciole di tanti personaggi che popolano le centosettanta pagine di questo prezioso libro si intrecciano in una narrazione corale ricca di personalità straordinarie.
Lorenzon e i suoi personaggi capaci di superare ogni difficoltà

Fanno da filo conduttore Nesto e Dele, che si amano da sempre. E che, nonostante le difficoltà e i drammi che costelleranno le loro esistenze, non si perderanno mai davvero.
Le violenze della guerra, del fascismo sempre più aggressivo, della povertà affrontata con dignità e coraggio, ma anche delle miserie umane che questa può determinare, non stanno solo sullo sfondo. Ma si dipanano ed emergono con forza senza scivolare nel didascalico o, peggio, nella retorica.
Più forti di qualsiasi ipocrisia
I pettegolezzi delle comari e l’invadenza e l’ipocrisia di Don Ortensio mettono prima alla gogna e poi al bando i due innamorati sorpresi ad amoreggiare tra le canne del fiume e costringono Dele ad andare a servizio a Venezia. La vergogna di un figlio disertore (Berto, lo zio di Nesto), fucilato mentre cercava di scappare dalla carneficina della Grande Guerra, ci immergono nella vita di trincea e nelle atrocità della prima linea.
La forza delle donne con la loro abnegazione e la loro tenacia, rimaste sole a gestire la quotidianità, ci mostrano la dura vita nei campi e nelle stalle. La cattiveria e l’immoralità del Conte, a capo di un manipolo di squadristi che tiene sotto scacco con pestaggi ed efferati delitti chiunque non si adegui al regime, mette in scena ciò che ha significato il fascismo nel nostro Paese. Eppure, nonostante le privazioni, la fatica, i lutti e le difficoltà che questa comunità deve costantemente affrontare, la narrazione procede spesso con brio e pagine davvero divertenti.
Strepitoso il capitolo dedicato alla reazione dei paesani davanti a una provocazione dei partigiani che fanno sventolare una bandiera rossa in mezzo a un canale. Esilarante la scenetta – gestita come un copione teatrale e degna di un Petrolini o di un Achille Campanile – nel capitolo “Atto unico”, che mette in scena l’orazione del prete successiva al misfatto.
La scrittura di Lorenzon si avvale di molti registri e di differenti forme narrative
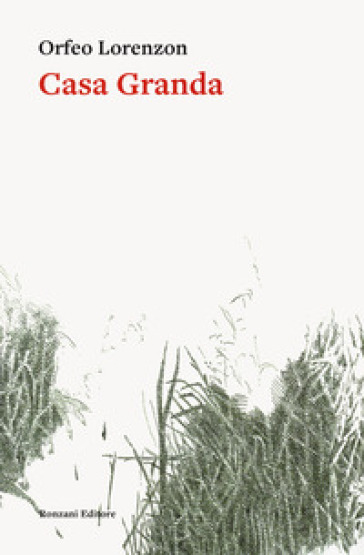
Dal dialogo drammaturgico serrato e collettivo del capitolo appena citato, all’atmosfera fiabesca del capitolo “La seconda storia di Barbapiccoli” che rivisita la storia de “La piccola fiammiferaia”. Il realismo irrompe nella narrazione, ricca di dettagli efficaci, della violenza subita da Cesarina, una ragazza muta, e del suo tragico parto. Così come anche della sofferta decisione di abortire buttandosi dalle scale di Dele. Perché, scrive Lorenzon: «[…] pensò che nessuno aveva il diritto di mettere al mondo altre anime in quel tempo.» (p. 139). Il dialetto, usato con competenza e vivacità, irrompe nei dialoghi, ma arricchisce anche spesso le parti più prettamente narrative. Termini come someja per “fotografia” ad esempio, in parte desueti o ormai poco frequenti, danno colore e sapore a un tempo passato.
Lorenzon e la vicinanza a Bortoluzzi

Chi ha amato i romanzi di Antonio G. Bortoluzzi (di cui si è parlato qui https://www.enordest.it/2022/10/09/la-montagna-e-madre-e-merita-una-trilogia/) amerà anche questo esordio di Orfeo Lorenzon. Vi troverà la stessa onestà intellettuale e un approccio alla vita di comunità molto simile. Vi riconoscerà lo stesso rispetto per un mondo perduto ma ancora a noi molto vicino, senza rimpianti e senza retorica mitizzazione.
Per questa ragione si ritiene che il romanzo sarebbe da portare nelle scuole per una lettura condivisa da affiancare allo studio del Novecento. Aiuterebbe i nostri giovani a comprendere non solo le nostre radici più recenti, ma anche i rischi che comporta una politica senza scrupoli senza etica e priva di attenzione verso le fasce più deboli della popolazione.
Un curiosità. Su Spotify è presente una playlist di canzoni collegate a Casa Granda. Utilissima per approfondire il contesto musicale del periodo storico in cui si svolge la storia.
Chi è Lorenzon
Orfeo Lorenzon, nato vicino a un’ansa del Sile, fiume al quale rimane legato, ama osservare le persone e la natura. Raccoglie storie, soprattutto quelle non dette a voce alta, e le racconta utilizzando varie modalità espressive. Preferisce le vite delle persone che spesso subiscono la grande Storia ma che, altrettanto spesso, ne sono le protagoniste. Ama ascoltare più che parlare e quando non può farne a meno scrive. Con Lucia Papa ha scritto e pubblicato sulla rivista «Insegnare» la fiaba L’isola della gente senza parole. Le storie di Casa Granda erano state salvate ancora prima e messe al sicuro in un cassetto.
Orfeo Lorenzon, Casa Granda, (Due Ville, VI), Ronzani, 2022.























































































Una recensione che coglie nel segno tutto il senso di quel bel libro, un’opera di poche pagine ma dense e profonde, che ripercorrono periodi difficili della guerra, con una leggerezza solo apparente. La recensione coglie proprio tutti gli aspetti importanti che fanno di Casa Granda un libro da non perdersi.
Grazie per l’apprezzamento!
Il libro merita di essere letto e fatto conoscere, bello e scritto con una scrittura misurata e volta, attendo la ps. prova di questo autore da conoscere assolutamente!
Sono d’accordo!
Molto interessante, grazie Annalisa Bruni!
Oggi più che mai dovremmo ritrovare la connessione con il nostro passato e con la storia, in particolare quella del Novecento, i cui insegnamenti, a volte, sembrano dimenticati. Per questo concordo con l’autrice dell’articolo che propone la lettura del romanzo nelle scuole come aiuto reciproco tra storia e letteratura per riflettere sulla vita.
Sono d’accordo con la bellissima recensione di Annalisa Bruni. È un grande canto corale e un omaggio ad un mondo ormai scomparso, ma che ci può insegnare ancora molto.
Bella recensione con la quale mi trovo pienamente d’accordo. Il narrare di Lorenzon è pulito e vibrante. Una prosa “completa” che nell’apparente semplicità, con tocco leggero ma incisivo – sfiora continuamente la poesia; il suo raccontare per fotogrammi richiama l’arte del collage: in qualche modo, senza dirlo apertamente è come rievocasse musiche lontane, delicatamente soffuse… . Si accosta alla forza e purezza di un film in bianco e nero. un libro che merita una rilettura per scoprire gli aspetti più profondi.