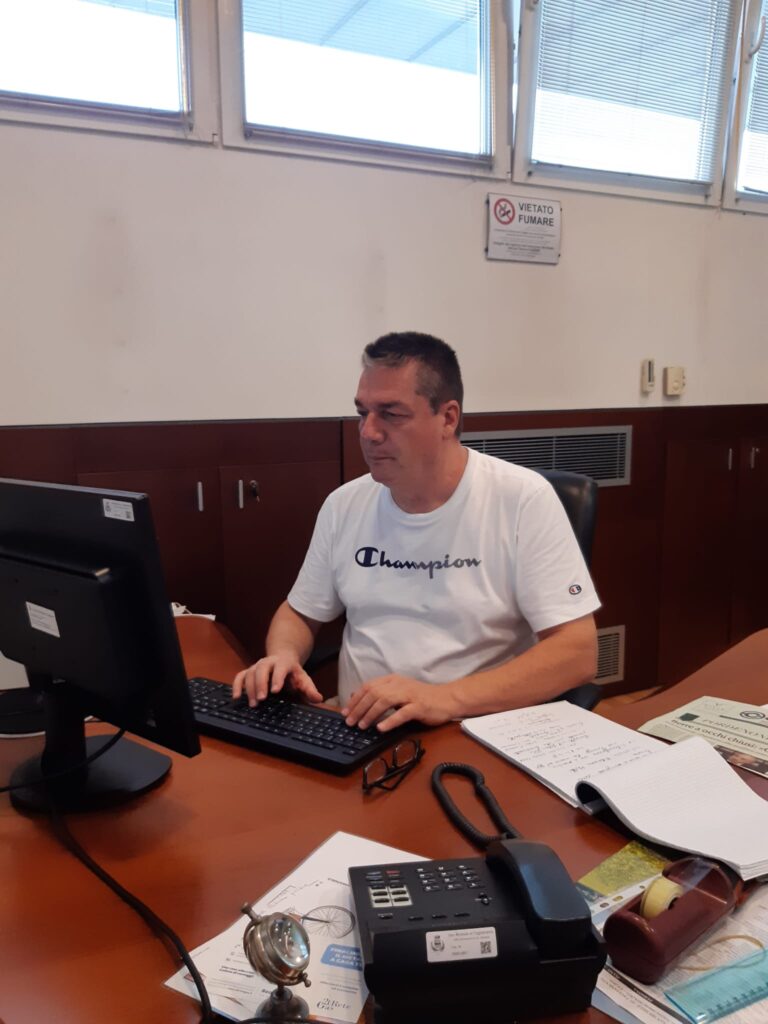I bombardamenti dei tedeschi e austriaci nel corso della Grande guerra avevano inferto un duro colpo al territorio di San Michele al Tagliamento. Un territorio all’epoca dove prosperavano già attività economiche ed era attiva una banca. Villa Ivancich era stata adibita ad ospedale militare per i soldati italiani prima della disfatta di Caporetto poi per le truppe austro-germaniche. Bibione all’epoca era una landa deserta. In queste pagine tragiche del secolo ventesimo si “inserisce” il complesso del faro di Punta Tagliamento-Bibione sorto negli anni immediatamente successivi alla fine della Grande Guerra. Venne edificato e messo in funzione per sostituire quello che sorgeva sulla sponda lignanese della foce del Tagliamento e che era stato demolito. Il primo documento ufficiale in cui compare il “faro” è la Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1937, mentre la prima foto è del 1925.
Il faro oggi
Il suo “ruolo” oggi è decisamente cambiato. Infatti il faro è diventato meta degli amanti dello slow-tourism e contribuisce all’economia del territorio: i numeri parlano chiaro, dall’inizio di aprile alla fine di settembre del 2019 ben 24.789 persone lo hanno visitato.
Il sindaco

Una bella soddisfazione per il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto e per l’assessore alle politiche comunitarie Annalisa Arduini: “Grazie ad una oculata gestione di fondi, tra i quali quelli europei, ben 15 persone hanno trovato occupazione tra faro e passo barca Bibione Lignano. Su questa strada si può e si deve proseguire, perché abbiamo capito che oggi il turismo non è solo spiaggia e ombrellone. E’ un turismo che “ruota” sì attorno alla spiaggia ma dobbiamo essere in grado di rendere appetibile il nostro territorio con tutte le sue potenzialità”.
Il faro durante la guerra
Di competenza della Regia Marina Militare Italiana e dipendente direttamente dal Comando della Piazza Marittima di Venezia, il “Caposaldo di Punta Tagliamento” (il toponimo “Bibione” arrivò solo nel 1937) fu presidiato stabilmente per oltre cinquant’anni da un distaccamento della Marina Militare, in quanto la sua nascita e il suo utilizzo erano finalizzati ad una capillare sorveglianza del tratto di mare alto-Adriatico tra Venezia e Trieste. Nel 1944-1945 venne requisito dalle truppe d’occupazione tedesche e tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio del 1945 presso Punta Tagliamento attraccarono decine di natanti della Wermacht e della Kriegsmarine carichi di soldati in precipitosa fuga dalle coste jugoslave, che toccarono terra attratti dalla sua luce avvistata in lontananza.
In mani inglesi
Dal giugno 1945 fino all’estate 1946 requisito dall’Esercito Inglese e contemporaneamente dentro torre e caseggiato trovarono fortunoso alloggio decine di sanmichelini sfollati, le cui case rase al suolo dai bombardamenti.

Dagli anni ’50 il faro di Bibione divenne un vero e proprio caposaldo strategico, in quanto era l’ultima installazione militarizzata costiera e punto d’osservazione marittimo prima del vicino confine con la Jugoslavia: il faro della Marina Militare della Repubblica Popolare Jugoslava di Punta Salvore distava meno di quaranta km in linea d’aria.
. _ . . . . _ _ . _
Nome in codice: LIMA. Era il nome militare, in codice Morse, del faro di Punta Tagliamento.
Chi lavorava al faro
Il distaccamento della Marina Militare in servizio al faro di Bibione era composto da tre sottoufficiali (un Capo, un Secondo Capo e un Sottocapo) e quattro marinai di truppa specializzati: un Segnalatore, un Metereologista, un Radiotelegrafista e due Marò. I loro compiti erano di: sorveglianza e avvistamento marittimo 24 ore su 24. Servizio Meteorologico di rilevazione dati. Emissione dei Bollettini Metereologici e degli “Avvisi ai Naviganti” trasmessi a Venezia tramite telegrafo alle ore 7:00, 13:00 e 19:00.
Le strumentazioni del faro
Alla strumentazione tecnica del Caposaldo, si aggiungevano una fotoelettrica ad alta potenza (alimentata dal generatore) dotata di alette movibili per la segnalazione notturna tramite codice Morse. E le 118 regolamentari “bandierine di segnalazione marittima”. L’armamento per la sua difesa in caso di attacco terrestre era composto da sette moschetti mod. 91 e un fucile mitragliatore Breda. La strumentazione di guarnigione comprendeva altresì un telegrafo a pile, una radiotrasmittente VHS inglese, un gruppo elettrogeno, una moto Guzzi 250, una bicicletta.
La sua luce
Tutte le strumentazioni conservate al primo piano, dove c’era l’ufficio del Comando, una stanza-armeria, una di telecomunicazione (telegrafica) e tre per l’alloggio del personale militare. Fino al 1951 la lampada del faro di Bibione funzionò esclusivamente ad acetilene. Il combustibile portato settimanalmente da un motoscafo blindato proveniente da Venezia. Solo in seguito arrivò la corrente elettrica.
Una storia antica

La Marina Militare appena messo in funzione il faro nei primi anni ’20 indisse un pubblico concorso per la gestione della torre, del caseggiato e delle altre strutture annesse all’installazione (il pozzo, la strada d’accesso, le siepi confinarie e tutte le lampade ad acetilene utilizzate per l’illuminazione notturna dei locali). Lo vinsero le famiglie Paro di Cesarolo, Gusso di Caorle e Zulian di Trieste. Che si trasferirono a vivere al piano terra del caseggiato annesso al faro. Il ruolo di “capoposto” (responsabile del personale civile) assunto da Evaristo Zulian, mentre a Luigi Paro andò la mansione di “fanalista” (raggiunta dopo il superamento di un corso). Ovvero di addetto al funzionamento e alla manutenzione della lanterna, della lampada e del sistema ottico del faro.
Il faro e una storia d’amore
Tra i marinai e le famiglie di civili alloggiate al faro ci fu sempre massima concordia e collaborazione e in un caso nacque pure l’amore. Nel 1952 un giovane marinaio pugliese si fidanzò di nascosto con la figlia, sua coetanea, di un farista. Dopo il congedo i due si sposarono.
(fonte: ricerche effettuate da Massimiliano Galasso)