Cominciamo con una raccomandazione. Prima di affrontare la lettura del romanzo Il violinista di Birkenau di Alessandro Zignani ascoltate il Lied Il re degli Elfi di Schubert, se non lo conoscete. Lo trovate anche su YouTube (qui una delle versioni):
La musica che accompagna la lettura

Il ritmo cupo, incalzante e ossessivo del pianoforte vi opprimerà il cuore, le parole vi risuoneranno nella testa, non riuscirete a dimenticarle. L’uno e le altre vi accompagneranno per tutta la narrazione, perché la musica è la sottotraccia di questa storia, spaventosa e tragica come questo Lied. Un padre cavalca nella notte stringendo a sé il figlioletto. La pioggia e le ombre sembrano al bambino, febbricitante, un elfo. La visione lo reclama, pretende di portarlo via con sé. Il padre rassicura il figlio, ma quando arriva a casa, il figlio gli muore tra le braccia. «I Lieder sono delle brevi canzoni dove ciò che non si dice è più importante di ciò che si dice.», scrive Zignani. «I bambini abusati da un genitore si inventano un personaggio mostruoso che sia autore del mostruoso atto.» L’elfo non esisteva, infatti: l’elfo e il padre sono la stessa cosa.
Quel violino a Birkenau

La voce narrante della prima parte del romanzo è quella di Joshua Singer, che viene nominato da Hermann Göring “cantore da camera”. I nazisti lo portano in tournée per dimostrare che solo gli ebrei cattivi avevano qualcosa da temere. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1978, a Berlino Est, durante le celebrazioni della Giornata della Memoria al Museo Ebraico – allora nella Kollegienhaus – incontra un vecchio che canticchia proprio quel Lied. Si chiama Mathias, è stato compagno di baracca di Isaac, suo figlio, nel campo di sterminio di Birkenau. Joshua ha avuto salva la vita, così come quella della moglie e dell’altro figlio, Abraham, in cambio di una scelta atroce, imposta da Göring. “Ero un ebreo graziato dal regime per meriti artistici […] la mia famiglia la lasciavano in pace perché c’ero io. Però non tutta. Tutta non si poteva”. Nel caso Joshua si rifiuti di sacrificare uno dei suoi figli, tutti e quattro verranno deportati. Tra Isaac e Abraham, la scelta straziante cade su Isaac, virtuoso del violino ma più fragile perché autistico.
Un’orchestra per un pubblico di morti
L’incontro con Mathias, anch’egli musicista, rivela a Joshua dettagli sulla vita del figlio nel campo, sulla crudele quotidianità dell’orchestra nella quale entrambi vennero costretti a suonare. Un’orchestra che “suonava per un pubblico di morti. […] Li tenevano in vita per lavorare e noi li svegliavamo la mattina, raccolti in file per un appello che poteva durare due ore e raccoglievamo la sera quanto di loro non si era perso nel sudore, le lacrime e la rabbia impotente.”
Se un violino a Birkenau può aiutare a sopravvivere
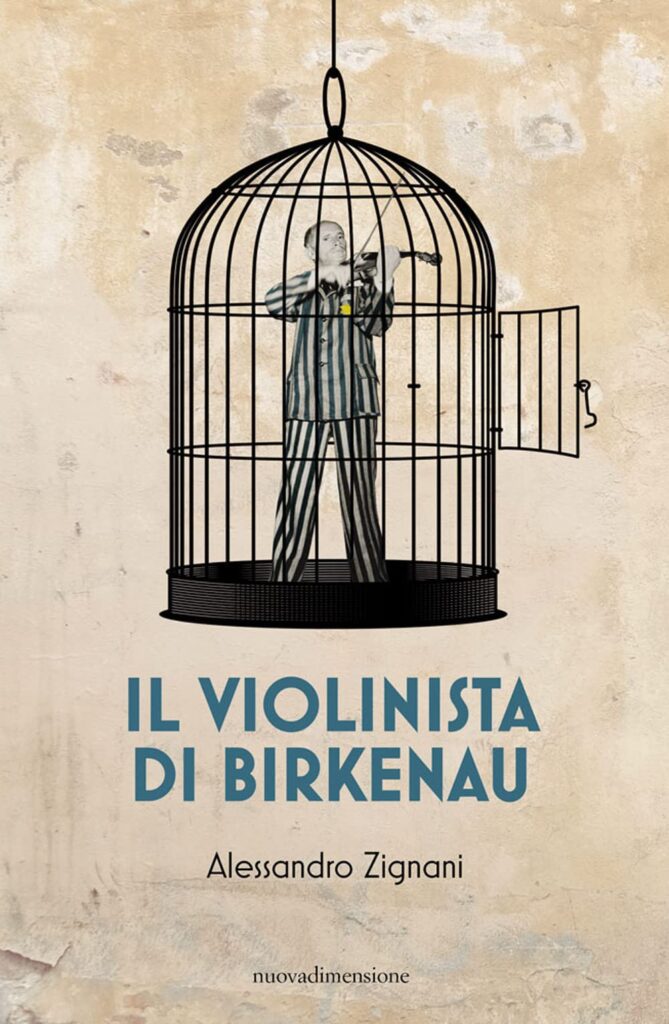
Nel racconto del vecchio riemergono i ricordi delle disumane condizioni imposte ai deportati. Non solo quelle relative alla fame, al freddo, alla fatica e alle malattie conseguenti. Sottili crudeltà come quella di non potersi lavare: “impedire di elevarsi al di sopra della condizione animale è una raffinata strategia di condizionamento”. Così come promuovere a Kapo qualche internato, dandogli dei privilegi sugli altri, ma creando i presupposti per soprusi e violenze tra persone che avrebbero dovuto invece solidarizzare.
In quella lunga conversazione Mathias racconta a Joshua come la musica di suo figlio, a Birkenau, sembrasse vincere la morte stessa e di come la loro orchestra avesse dato la forza a tanti per sopravvivere.
Il diario
La seconda parte del romanzo riporta il diario di Mathias, scritto durante la prigionia su fogli di fortuna e poi continuato dopo la fine della guerra. Fogli che consegna a Joshua prima di suicidarsi gettandosi dalla Torre della Radio di Berlino. Mathias non è ebreo: viene deportato in quanto omosessuale e nel campo incontra Otakar, selezionatore di musicisti per l’orchestra, che lo proteggerà in cambio di favori sessuali. Nello stesso campo di Birkenau si trova il compositore Marcel Tyberg. Lì scriverà una sinfonia incompiuta, la numero 3, che dopo la sua morte sarà completata da Jsaac.
La musica, dunque, impregna questo romanzo e ne diventa la cifra simbolica in un crescendo di riflessioni sulla Germania nazista, sulla natura dei Tedeschi, sulla complessità della sua storia recente, ma anche sul ruolo e l’importanza che essa ha avuto in quel tragico frangente.
La musica che unisce anche dopo Birkenau

La narrazione di Zignani procede con una terza parte nella quale prende la parola Julie, vedova di Tyberg, che nel dopo guerra incontra Mathias e se ne innamora. Lo sposerà, nonostante il suo passato, o forse proprio per questo. Qui la scrittura si fa bisturi, seziona ogni recondito, inconfessabile anfratto dei sentimenti umani, soprattutto i più contraddittori. Julie è una giornalista, sarà incaricata di seguire e filmare Joshua durante una sua tournée di recital nelle città tedesche distrutte dalla guerra: Dresda, Norimberga, Heidelberg, Friburgo. “Le due Germanie, nel 1978, erano pregne di musica. La musica era l’elaborazione pubblica di un lutto che in privato era negato. Si voleva continuare a funzionare, e funzionare, per un Tedesco, era più importante che pensare. […] I signori della musica, nelle due Germanie di allora, erano spesso o nazisti, o divi protetti dal regime”. L’incontro tra Julie e Joshua sarà piuttosto uno scontro che si concluderà in una diretta televisiva senza esclusione di colpi, crudele e spietato come il passato che è impossibile dimenticare, per entrambi.
L’epilogo del romanzo, ispirato a una storia vera, è affidato a Joshua, che prende nuovamente la parola. Il lettore a questo punto non può che continuare a interrogarsi sulla natura umana e sul ruolo e le conseguenze che la musica le infonde e determina.
L’autore

Alessandro Zignani è un musicologo, scrittore e germanista. Per Guaraldi ha pubblicato i romanzi: I mondi paralleli (Segnalazione al Premio “Stresa”), Musica del mondo, Telemaco: l’odissea della scuola (Menzione Speciale al Premio “Firenze-Europa”), L’orecchio interiore (Premio Internazionale “Maestrale-Marengo d’oro” 2000). Successivamente sono usciti, presso Zecchini, Il canto sospeso (Premio Internazionale “Maestrale-Marengo d’oro” 2002), Il divertimento e l’estasi. La danza di Arione (Raffaelli editore), La porta chiusa in cielo (AIEP), Di nessun domani (Bastogi). Come musicologo ha collaborato con varie riviste, tra cui “MUSICA” di Zecchini editore, oltre che con molti teatri italiani. È stato a lungo docente di Storia della Cultura tedesca. Attualmente è titolare di Storia della Musica ed Estetica Musicale presso il Conservatorio-Istituto di Alta Cultura di Monopoli (Bari). Ha tradotto Nietzsche, Trakl, Seneca, Spinoza, e molta liederistica tedesca. Per il teatro ha scritto e messo in scena Il sogno di Prometeo, Viaggio d’inverno e Il violino di Ivry. Con il radiodramma Mia madre è stato finalista al Premio “Candoni”. Ha scritto e diretto un film, L’arte della fuga, nell’ambito del progetto “Bach-Berio” dell’Unione Europea. Ha pubblicato con Zecchini Editore numerosi libri sulla musica, tra cui ricordiamo: un libro su Wilhelm Furtwängler, Il suono e il respiro; Manuale di sopravvivenza per il musicista classico; S.P.A.S.M.O.Il Quiz della Musica; A.S.S.U.R.D.O. Ricognizione paradossale nella didattica musicale di ogni conservatorio. Nel 2020 esce per Ediciclo I sentieri della musica. Con Nuova Dimensione pubblica Il violinista di Birkenau, nel 2023.






















































































