Nel 1993, giusto 30 anni fa moriva a Venezia, il giornalista del Gazzettino, Fiorello Zangrando. Bellunese di Perarolo di Cadore, grande esperto di cinema e di Biennale alla redazione di Venezia. Aveva appena 58 anni. Va ricordato in questi giorni di commemorazioni del Vajont, perché Fiorello Zangrando, nel 1973, scrisse con il fotografo Giuseppe Zanfron il libro “Memoria di una distruzione”. Volume che rimane una testimonianza non ideologica e obiettiva sugli errori umani e le colpe criminali di tecnici e politici. A 60 anni dalla tragedia del Vajont pochi si sono ricordati di lui: perché è stato dimenticato?
Chi era Fiorello Zangrando

Fiorello era nato in un paese dolomitico, patria degli zattieri che arrivavano in laguna via torrente Boite e fiume Piave, dove non esisteva né un cinema, né un teatro, né una Biennale, eppure ne divenne uno dei massimi esperti. Il suo primo “pezzo” a 17 anni, liceale, lo portò in calzoni corti alla redazione di Belluno nel 1952, dedicato alla lenta decadenza degli zattieri del Piave e di conseguenza alla sua Perarolo. Cento anni fa il paese contava oltre duemila abitanti oggi ridotti a poco più di 300. Nel 1956 scrisse un importante saggio: “Il decadimento industriale e commerciale di Perarolo di Cadore”. Come storico anticipava i tempi. Era figlio di emigranti andati a lavorare nei posti più sperduti del Brasile e poi tornati tra i monti di casa.
Zangrando, non me ne voglia Edoardo Pittalis, all’epoca vice-direttore del Gazzettino, lo chiamò un paio di settimane prima di morire, era ricoverato all’Ospedale Civile di Venezia, per chiedergli un pezzo su un famoso attore americano degli anni ‘40, Dana Andrews. Fiorello, dall’ospedale, lo dettò a braccio, al telefono, senza sbagliare una virgola. Il pezzo era perfetto. Era il periodo prima di Natale. Ai primi di gennaio, senza aver mai lasciato l’ospedale, Fiorello Zangrando se ne andò.
Il mio ricordo di Fiorello Zangrando

Mi emoziona ricordarlo perché ebbi la fortuna di entrare nella redazione del Gazzettino di Venezia, giusto il passaggio tra lo storico palazzo Ca’ Faccanon e la sede di campo San Luca, tra il 1977-78. La redazione era una commedia goldoniana continua e vivente. Paolo Rizzi, il capo, grande esperto e critico di arte contemporanea, Leopoldo Pietragnoli, storico e cronista veneziano meticoloso, al quale potevi chiedere in che anno era stata posta una pietra in piazza San Marco. Poldo, come lo chiamavano, lo sapeva con precisione. Eppoi l’inviato Gianpiero Rizzon, per i fatti importanti, Fabio Marangoni, cronista di “bianca”, Bepi Tedesco di “nera”, Giorgio Nordio, per le rubriche e “l’angolo del degrado” (esisteva già allora a Venezia, al Gazzettino, prima dell’arrivo del turismo di massa…).
Poi bussava quotidianamente alla porta della redazione un certo Nantas Salvalaggio, per proporre i suoi articoli di costume e cultura. Mentre il giorno dopo arrivava il giornalista Piero Zanotto, a proporre i nuovi fumetti di Hugo Pratt e di Corto Maltese a Venezia.
Redazione università di vita

“Poldissimo?”. Dimmi Fiorellissimo”. Era il dialogo quotidiano tra Pietragnoli e Zangrando. “Secondo te, Carlo Ripa di Meana (presidente della Biennale, ndr) fa bene a organizzare la Biennale del dissenso contro l’URSS? Risposta di Zangrando. Fa benissimo, dovrebbero chiamarlo Ripa di meona (ndr, testa grande in dialetto). Fiorellissimo? Dimmi Poldissimo. Cosa pensi della rivolta studentesca e delle Br? Sono tutti figli di papà borghesi, nessuno che lavori veramente.
Insomma la redazione veneziana di allora era una specie di università della vita.
Il rapporto con il Gazzettino

Fiorello Zangrando, prima di diventare veneziano residente a Cannaregio, aveva un passato illustre come giornalista e scrittore in Cadore. Il suo libro “Dolomiti, universo bellunese” è ancora in vendita. Laureato a Padova con una tesi premiata con 110 e lode “Storia giuridica del Cadore”, per poco tempo giovane avvocato, preferì fare il cronista a differenza di suo fratello Peppino, partigiano, che divenne celebre come difensore parte civile del disastro del Vajont per il Comune di Longarone.
Fiorello, entrato alla redazione del Gazzettino nel 1963, l’anno del disastro, nel 1966 divenne il più giovane capocronista della sede di Belluno, poi fu nominato inviato speciale e critico cinematografico. Il grande fotografo e cineasta Francesco Maria Pasinetti, fu una delle sue scoperte. Fu inviato per ben 14 anni di seguito alla Mostra del Cinema. Seguì per anni all’Aquila il processo contro la Sade-Enel per i 1910 morti della diga maledetta e nel 1969 ricevette il Premio Margutta, come miglior giornalista del mese, a livello nazionale. Nel 1987 gli consegnarono il prestigioso premio Piva.
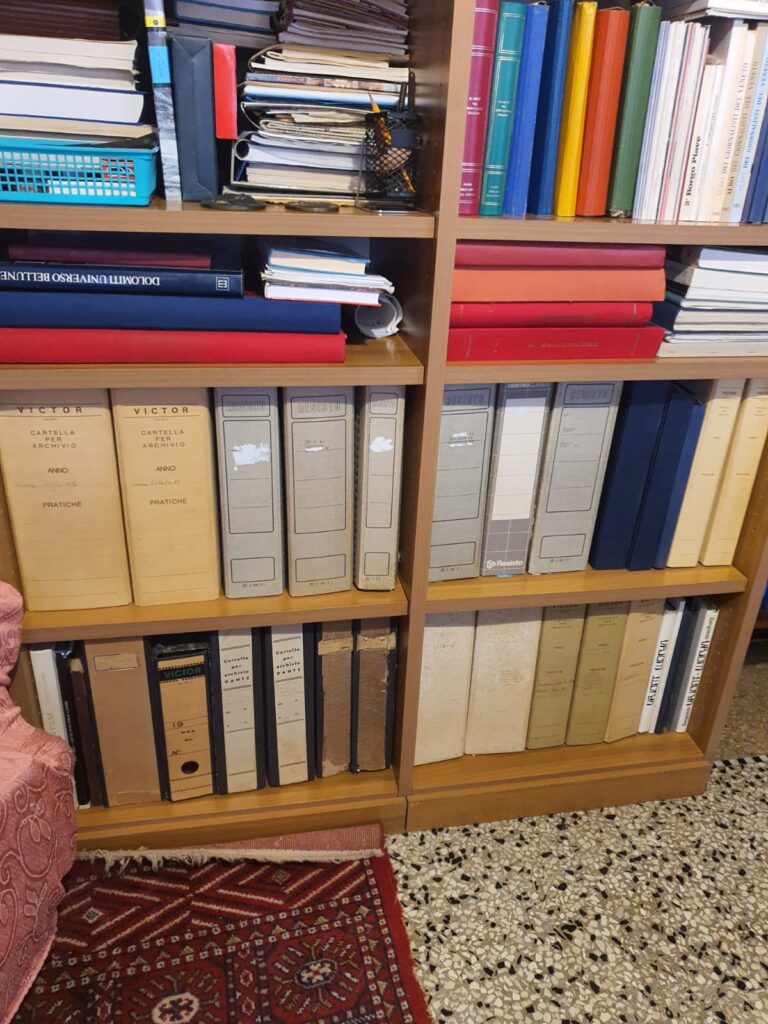
Un giorno mi disse: ma tu sai cos’è Venezia? No. È lo sbocco a mare del Cadore.
Ho un ricordo, da modesto abusivo, in una redazione così importante. Un giorno scrissi un articoletto con il “ne” con accento grave. Mi corresse Fiorello. Caro praticante giornalista, se c’è l’accento è sempre e solo acuto, mi raccomando, è una congiunzione negativa. Mentre senza accento è un avverbio di luogo o un pronome. Grazie Fiore! Prego maestro.























































































Bellissimo ricordo di un grande giornalista!