Proprio ieri, nel corso di una conversazione – molto interessante e prospettica sul presente e sul futuro – con un amico, ho sentito un vecchio detto veneziano. Senza pretendere di trascriverlo in originale, in italiano suona come: “perché passi una pandemia servono due Pasque e un Natale”. Ora, senza fare troppa fatica con i conti, questa è decisamente la seconda Pasqua in pandemia e tutti ricordiamo come è stato questo Natale. Una cosa che ho imparato in anni di studi e ricerca è prendere molto seriamente la saggezza popolare: spesso ciò che i ricercatori provano con il metodo scientifico è già stato in qualche modo intuito e tramandato tra le generazioni. Per cui prendiamo questa frase come un buon auspicio, tutto da provare, dotato però anche di un certo credito in partenza. Se fosse vero che ci avviamo al momento in cui usciremo dalla fase acuta della pandemia sarebbe necessario investire tempo ed energie per riflettere sul passato, sul presente e sul futuro, perché entreremmo in un periodo in cui sarà necessario prendere le migliori decisioni per la società e per il paese.
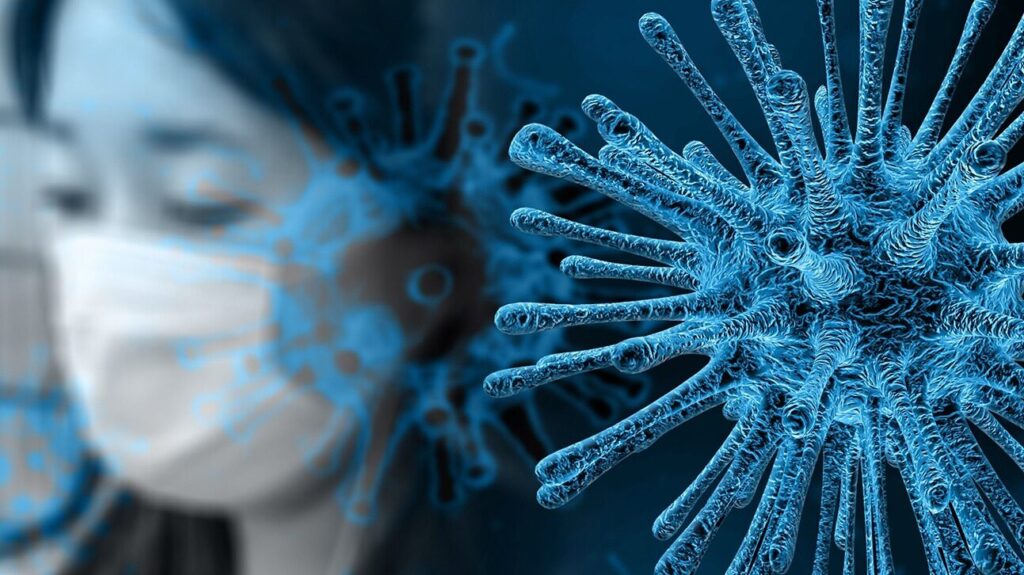
Gli errori del passato e gli insegnamenti per il futuro
Partiamo chiarendo un punto molto importante: lo stato attuale delle cose non è diretta conseguenza di un lassismo estivo generalizzato e specialmente ascrivibile ai giovani. È vero che si sarebbe potuta abbassare ancora di più la quantità dei contagi, peraltro diventata esigua in agosto, ma bisogna tenere in conto due fattori fondamentali. Il primo è che le persone erano esauste, il secondo è che l’Italia non è la Nuova Zelanda: tra viaggi d’affari, immigrazione, turismo e affini il virus sarebbe rientrato nel nostro paese entro ottobre. Questo è un elemento che anche scienziati estremamente rispettabili e precisi nelle loro previsioni fanno fatica a comprendere: il fattore umano è impattante quanto le modalità e velocità di diffusione del virus. Nel futuro gli amministratori a tutti i livelli dovranno coltivare la capacità di comprendere cosa è possibile chiedere alla popolazione e come comunicarlo.

Natale è un’altra storia, purtroppo. In quel frangente in tanti, me compreso, avevamo suggerito di sfruttare il periodo delle feste per una chiusura totale di almeno venti giorni. Sarebbe stata dura ma ancora sostenibile, almeno economicamente. Il Governo non se l’è sentita, anche per ragioni comprensibili come quella di salvaguardare la tradizione, e stiamo pagando questa scelta con mesi di zone arancioni e rosse. La situazione del Natale è emblematica di un altro meccanismo rispetto all’estate: non si può chiedere sempre il sacrificio, ma a volte bisogna farlo ed avere sufficiente autorevolezza per essere ascoltati. Nel futuro dovremo tutti, governanti e cittadini, avere il coraggio di prendere le decisioni giuste.

Un errore fondamentale è stato quello di non affrontare con energia la diffidenza tutta italiana al tracciamento. Da una parte bisogna dire che il piano che aveva come terminale l’app Immuni non dava l’impressione, almeno all’esterno, di garantire completamente efficacia e affidabilità. E non bisogna nemmeno dimenticare che il tracciamento, in un paese democratico, deve avere paletti precisi: non siamo e non dobbiamo diventare un paese totalitarista. Però la società e i governanti si sono piegati troppo velocemente alle voci ipercritiche e iperscettiche, quando invece i paesi che hanno gestito meglio la pandemia hanno tutti applicato forme di tracciamento. Nel futuro dovremo impiegare molte energie per creare condivisione sui temi importanti che coinvolgono tutti, diffondere l’alfabetizzazione civica e scientifica a tutti i livelli, crescere come paese e come società.
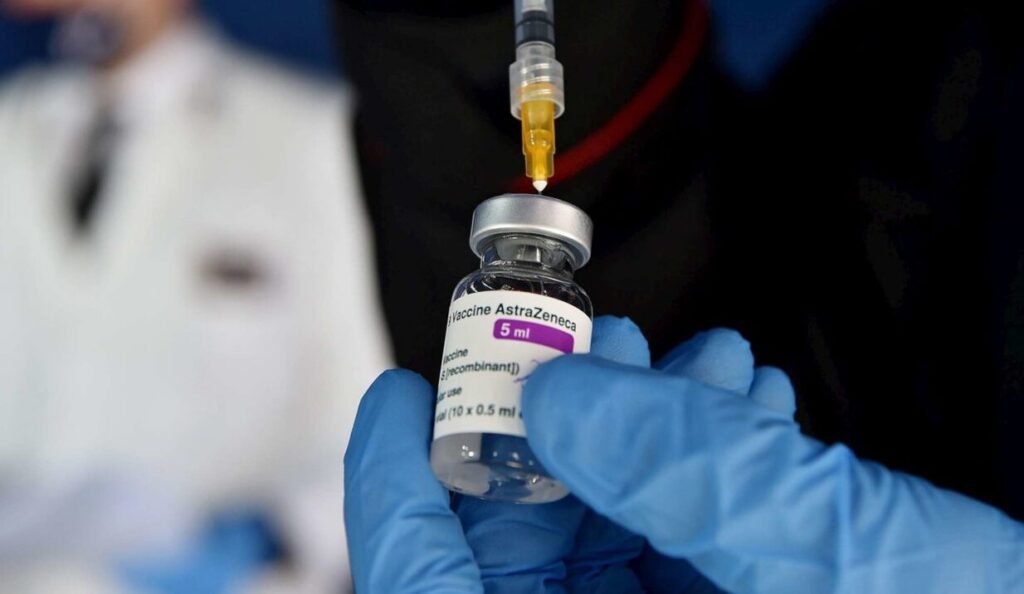
Ultimo ma non ultimo errore, la gestione della campagna vaccinale e la comunicazione sociale non sono all’altezza di un paese che dovrebbe ancora essere leader nel mondo. Una parte fondamentale della ripresa dell’Italia passa dalla costruzione di credibilità all’interno del paese e rispetto agli altri stati. Con la fiducia tra governanti e popolazione si può costruire la legittimità di azione, ma questa deve basarsi su azioni portate avanti con efficacia ed efficienza e sulla base di una programmazione degna di tale nome. In futuro chi governa dovrà ricercare l’efficacia nelle proprie azioni per guadagnare fiducia, e la cittadinanza dovrà avere alti standard nello scegliere i propri rappresentanti e avere migliore memoria nel ricordare i comportamenti, la coerenza e le competenze in chi vuole mettersi a disposizione della comunità.
Guardare con onestà al nostro passato prossimo

Confidiamo che il vecchio detto veneziano abbia ragione e che prima dell’estate si possa guardare al futuro con maggiore fiducia. Dobbiamo sperarlo con tutte le nostre forze anche perché il diffondersi del disagio psicologico sta diventando un problema tale da rappresentare una seconda pandemia e c’è bisogno di ripartire. In qualità di studioso ritengo che tenere tutto chiuso ancora per troppo tempo potrebbe avere effetti peggiori che la circolazione del virus in una popolazione vastamente vaccinata e in condizioni climatiche da primavera inoltrata. Ma la fine di questa fase della pandemia, in sé, comporterebbe rischi molto elevati: entrare in un futuro così diverso e ricco di possibilità senza aver affrontato il passato e imparato dagli errori è come fare trekking con una benda sugli occhi.
Abbiamo grandi opportunità di fronte a noi ma tantissime scelte da compiere. Cosa diventeranno le nostre città? Quale sarà il posto dell’Italia nel mondo? Quali saranno i settori produttivi da sostenere? Come costruiremo una società in cui telematico e presenza convivano? La risposta non è ancora svelata, ma certamente passa dal guardare con onestà al nostro passato prossimo.






















































































