In questi giorni stiamo assistendo a un evento di portata storica, di cui pochissimi hanno avuto esperienza diretta nel corso della loro vita. Si tratta ovviamente della guerra tra Russia e Ucraina, un conflitto che ha caratteristiche molto particolari e, quindi, forti effetti sul pensiero individuale e collettivo. Per delineare solamente due caratteristiche della situazione che stiamo vedendo, si può considerare che si tratta di una guerra in piena Europa che coinvolge una potenza mondiale e nucleare “esterna”. Certamente molti lettori hanno visto conflitti recenti in Europa, le diverse guerre nei Balcani, ma si trattava di conflitti regionali tra piccoli stati e in cui la partecipazione estera è stata condivisa e internazionale. La percezione che ci potesse essere realmente un’escalation non è stata mai veramente condivisa e primaria. Ci sono state guerre, più o meno prolungate, recenti che hanno coinvolto grandi potenze – gli USA in Afghanistan e Iraq, la Russia in Georgia – ma si trattava di conflitti distanti e comunque, in un certo senso, localizzati. Oggi l’effetto sulla percezione di sicurezza e di futuro per tutti noi è diverso.
Incertezza prolungata e effetti psicologici

L’incertezza è uno dei maggiori stressor – fonte di stress – che si possa esperire. Specialmente se l’incertezza è prolungata o riguarda aspetti centrali nella vita delle persone, l’effetto che può avere è estremamente rilevante. Le conseguenze della prolungata esposizione allo stress legato all’incertezza può avere effetti psicologici (primo tra tutti l’ansia), fisiologici (come problemi gastrointestinali o cardiovascolari) e comportamentali. Si tratta, dunque, di ricadute e estremamente concrete che impattano nella vita di tutti i giorni. Dal punto di vista individuale, quindi, un mondo imprevedibile e pericoloso, in cui si passa da una pandemia alla guerra, causa forte disagio.
La percezione collettiva
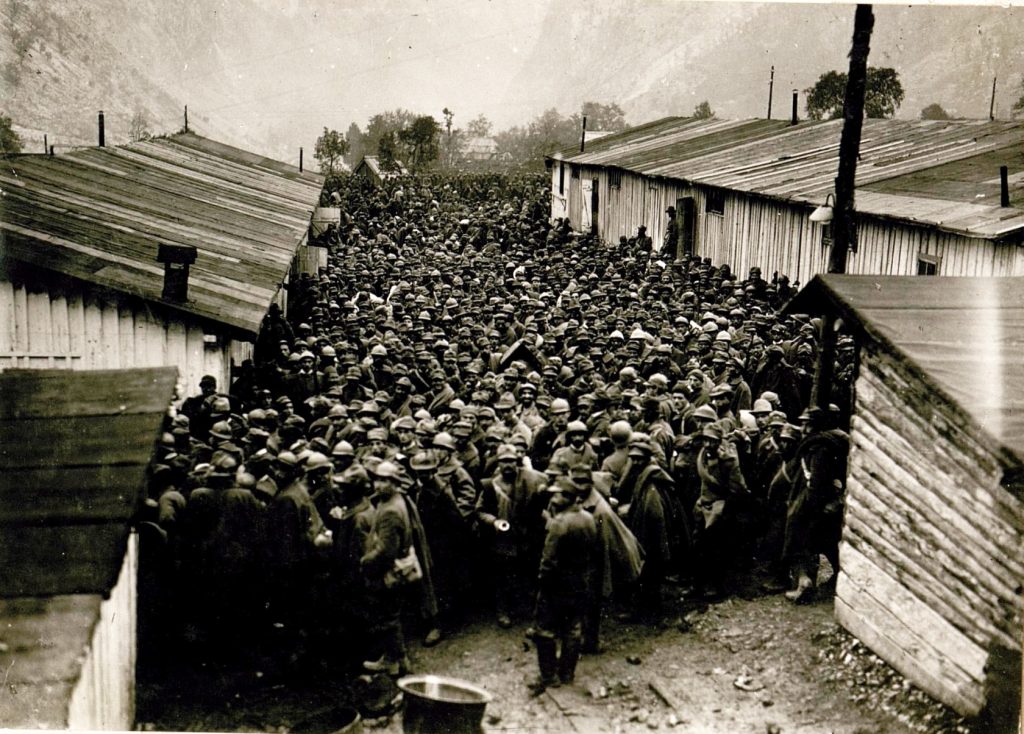
Ma l’incertezza non è solamente un fatto individuale, è anche un costrutto sociale. Una guerra di grande portata a pochi chilometri dai nostri confini è un elemento di destabilizzazione a livello sociale. Il modo in cui interagiamo con gli altri è fortemente legato all’idea di poterne prevedere la reazione. Questo vale a livello di individui ma ha una trasposizione nel comportamento collettivo delle popolazioni, nelle relazioni tra gli stati, nelle scelte aziendali, nell’economia. Nel passato avevamo un’idea di mondo sicuro, ordinato e unipolare degli anni ’90 – a seguito del crollo dell’URRS e con l’egemonia americana – che poi si è evoluto, dopo l’11 settembre, a un mondo ancora unipolare e con regole chiare in cui sacche di dissenso si manifestavano con il terrorismo. Adesso bisogna pensare a un mondo multipolare, in cui non è facile individuare una guida e non ci sono regole chiare e definite.
Una specie di caduta dell’Impero Romano

Volendo fare un paragone storico si può pensare alla caduta dell’Impero Romano (che comunque è stato un processo di almeno più di un secolo) e lo sviluppo di diversi regni e potentati alto medievali. Immaginiamo come gli ultimi Romani, abituati a pensare a un mondo in cui l’Impero era forte e dettava le leggi, abbiano vissuto gli scontri tra piccole realtà incapaci di prevalere decisamente l’una sull’altra. E proprio in quel periodo sono nate, appunto, fortificazioni e castelli diffusi in tutta Europa. Si può pensare sia stato un momento di mescolamento delle carte dopo secoli di relativa calma, ma sicuramente è stato un periodo complesso e difficile. Dobbiamo cominciare, anche a livello di Paese e di Europa, a pensare che per avere un certo grado di sicurezza e di “peso” sarà necessario avere un atteggiamento attivo e proattivo. Il resto del mondo corre, siamo noi che siamo rimasti con l’idea che l’occidente e l’America fossero egemoni. La guerra ai bordi dell’Europa ci ha dato un segnale forte, e la psiche individuale e collettiva dovrà evolvere e non soccombere all’incertezza e alla tensione.






















































































