Andrea Cerica è un giovane studioso mestrino che ha dedicato dieci anni della sua vita a studiare Pier Paolo Pasolini con competenza e passione. A coronamento di tanta dedizione, nell’anno in cui se ne sta celebrando il centenario della nascita, sono usciti ben due libri frutto delle sue ricerche.
Il lavoro di Cerica
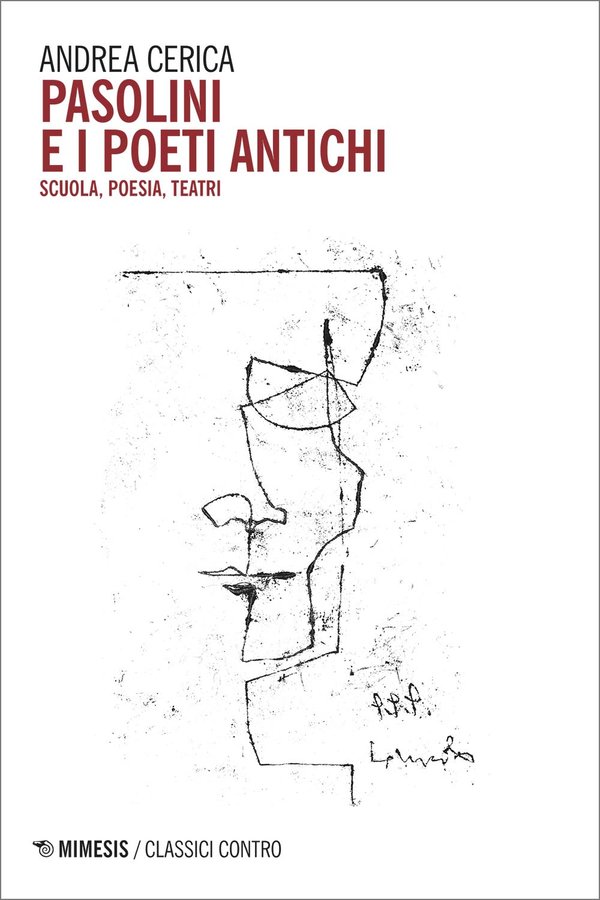
Il corposovolume intitolato Pasolini e i poeti antichi. Scuola, poesia, teatri, (Milano – Udine, Mimesis, 2022, pp. 510) parte da alcuni interrogativi: quali e quanti sono gli autori greci e latini più importanti per Pasolini? In che modo questi ha scelto di prestare loro penna, cinepresa e corpo?
Pasolini e la tradizione classica
È molto interessante infatti approfondire un aspetto apparentemente contraddittorio della poetica pasoliniana avendo come intento quello di rispondere a un’altra domanda: perché in tutta la sua opera poetica, letteraria, saggistica o multimediale, un intellettuale che si riteneva “più moderno di ogni moderno” e così anticonformista da definirsi “corsaro”, ha dato tanto spazio a una tradizione conservativa, gerarchica ed elitaria, quale è la tradizione classica?
Le risposte di Cerica

Andrea Cerica ha voluto, attraverso i suoi studi, dare una riposta a queste domande, prendendo in considerazione la vita e l’intero corpus “greco-latino” di Pasolini, dalle opere più precoci realizzate tra Bologna e Casarsa fino a Petrolio/Vas. Fino ad ora i critici, nell’affrontare questa tematica, si erano limitati a considerare una piccola parte dell’ampia opera pasoliniana: ossia cinema (Edipo re, Medea, Appunti per un’Orestiade africana), teatro (Pilade, Affabulazione) e traduzioni (Orestiade, Il vantone) degli anni ’60, anche se va detto che non si sono dimenticati di guardare ad altri periodi (anni ’40, ’50 e ’70) e ad altri generi e forme d’arte (narrativa; saggi, articoli e recensioni; poesia; pittura), ma l’hanno sempre fatto marginalmente.
Un nuovo studio
Questo nuovo studio di Cerica, invece, ha voluto mettere a fuoco per la prima volta ‘tutto’ il corpus “greco” e “latino” di Pasolini, dai primi versi incerti fino al celebre romanzo-summa (appena riedito da Walter Siti e Maria Careri per i tipi di Garzanti), e lo ha fatto con particolare riguardo per quanto è stato omesso fin qui e oggi è tendenzialmente giudicato inferiore rispetto al regista o all’autore di Petrolio, cioè per il Pasolini bolognese, friulano e dei primi anni romani. Un lavoro titanico ed ecomiabile, quello di Cerica, di cui ogni pasolinista non potrà non tener conto nei prossimi anni.
Il “loro dio” di Cerica

Nel volume «Un loro dio». La poesia di Kavafis nel primo romanzo di Pasolini, Andrea Cerica offre al tempo stesso uno studio comparato di due ‘poeti’ (Pasolini e Kavafis) e un saggio su Amado mio, il primo ‘romanzo’ di Pasolini.
Non si tratta però di una comparazione teorica, ma di uno studio filologico della ricezione di Kavafis in una singola opera di Pasolini, Amado mio, appunto, letta in tutte le sue fasi evolutive, dal primo abbozzo (1947), di cui parla il lunghissimo cap. I e che è quindi il vero protagonista, al sequel romano (1950).
L’esempio di Kavafis

Pasolini fu uno dei primi poeti a cogliere la grandezza di Konstantinos Kavafis, tanto da tentare di seguirne l’esempio: quando lesse la prima antologia italiana del neogreco, pubblicata da Filippo Maria Pontani nel 1945 (secondo fascicolo della rivista romana “Poesia”), egli scelse come argomento portante di Amado mio (197-19590) l’amore estivo tra un giovane letterato e un adolescente dalla bellezza divina, che chiamerà Iasis come il ragazzo di un famoso epigramma dell’Alessandrino.
La ricerca di Cerica
Cerica ricostruisce con rigore e competenza per la prima volta l’influenza del poeta neogreco sul giovane Pasolini e allo stesso tempo l’evoluzione, attraverso tale influenza, del romanzo originato da quella lettura: evoluzione che non ha soltanto a che fare con le dinamiche testuali interne a questo singolo testo pasoliniano, ma anche con alcuni temi-chiave dell’opera completa di Pasolini (narcisismo, morte, bellezza adonia).
Non un libro su Kavafis ma uno studio su Pasolini
Il saggio aggiunge un capitolo importante alla fortuna novecentesca di Kavafis in Italia (ancora del tutto sconosciuto ai neoellenisti sia d’Italia sia di Grecia), ma è soprattutto un libro su Pasolini, studiato in realtà non solo attraverso il legame con il coprotagonista Kavafis, ma anche con tutti gli altri poeti letti assieme all’Alessandrino intorno alla metà degli anni ’40 e presenti nel romanzo: Tommaseo, Saffo, Machado, Jiménez, Trakl, Eliot, Pascoli.
Chi è l’autore dei due volumi

Andrea Cerica (Venezia, 1990), diplomato al Liceo classico “Raimondo Franchetti” di Mestre, si è laureato in lettere antiche a Ca’ Foscari e ha conseguito il dottorato di ricerca nella medesima disciplina all’Università di Pisa, con una tesi vincitrice nel 2019 del XXXV Premio Pasolini (Pasolini e i poeti antichi, Mimesis, 2022). Al momento collabora con la Cineteca di Bologna; è inoltre insegnante nei licei pubblici, assistente alla didattica e docente a contratto di lingua greca a Ca’ Foscari.
Andrea Cerica, Pasolini e i poeti antichi. Scuola, poesia, teatri, Milano – Udine, Mimesis, 2022
Andrea Cerica, «Un loro dio». La poesia di Kavafis nel primo romanzo di Pasolini, Pisa, Edizioni ETS, 2022






















































































Brava Annalisa! La tua analisi sempre lucida e articolata!
Grazie!